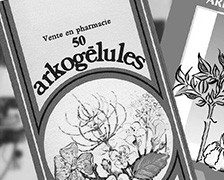Come vengono formulati i nostri prodotti?
Sappiamo che date molta importanza alla composizione dei prodotti per la salute che utilizzate. Per questo è nostro dovere e responsabilità selezionare solo ingredienti di qualità per formulare soluzioni naturali. Questa ambizione si concretizza nel concetto di "Galenica Verde".

"Galenica Verde" di Arkopharma: che cos'è?
"La galenica verde è un concetto che combina sia la formulazione di prodotti per la salute che l'uso esclusivo di ingredienti di origine naturale."
Chantal Hombourger, Direttore Sviluppo Galenico Laboratori Arkopharma
La galenica è la scienza e l'arte di preparare un principio attivo in modo che possa essere somministrato in una forma adatta e facile da usare: capsule, compresse, fiale bevibili, ecc. Il risultato è una forma galenica, un prodotto facile da somministrare e da usare. Una forma galenica si ottiene mescolando i principi attivi con le materie prime utilizzate nella formulazione, note come "eccipienti" o "additivi", per ottenere la forma desiderata e garantirne la stabilità.
Fin dalla fondazione di Arkopharma, abbiamo cercato di formulare i nostri prodotti utilizzando principi attivi di origine naturale, principalmente vegetali. Questi principi attivi sono contenuti nel totum della pianta, cioè in tutti i suoi componenti che agiscono in sinergia. Per formulare un prodotto, aggiungiamo le materie prime ai principi attivi per ottenere le proprietà finali. Per rimanere fedeli ai nostri valori, abbiamo scelto di non utilizzare additivi chimici, nanoparticelle o coloranti sintetici.
Oggi, quindi, tutte le nostre formulazioni utilizzano solo ingredienti esclusivamente naturali.


La "Galenica Verde" di Arkopharma: un lavoro brevettato
Ogni anno testiamo centinaia di materie prime grezze come mela, avena, grano saraceno, farina di banane, ecc. per sostituire ogni materiale sintetico delle nostre formule.Grazie al lavoro dei nostri ricercatori, abbiamo scoperto che queste materie prime possiedono intrinsecamente delle proprietà tecnologiche che, miscelate con i nostri attivi, potrebbero conferire proprietà tecniche al prodotto, consentendone la formattazione finale. Questo lavoro è stato brevettato nel luglio 2018.
"Per garantire la stabilità di queste preparazioni, abbiamo sviluppato anche metodi di previsione della stabilità, permettendo così di offrire ai nostri consumatori prodotti sicuri, efficaci e naturali, fino alla loro scadenza."
Chantal Hombourger, direttore Galenic Development Laboratori Arkopharma
Soluzioni galeniche adatte
La competenza nella galenica dei nostri laboratori si basa sulla nostra capacità di innovare. Il nostro servizio galenico riporta gli attivi potenzialmente interessanti, recentemente lanciati sul mercato internazionale e oggetto di seri studi, ma anche gli eccipienti. È questa conoscenza del binomio attivo/eccipiente che permette ai nostri galenici di adempiere alla loro missione: facilitare l'uso e il consumo di integratori alimentari, in cui l'attività e l'efficacia degli ingredienti sono preservate.Soluzioni galeniche adatte

Il reparto galenico deve anche risolvere altri problemi, in particolare quelli del sapore nei prodotti liquidi. Le piante sono spesso caratterizzate da una amarezza naturale, la cui incidenza è tanto più importante in quanto sono in forme liquide e bevibili.
Il ruolo del servizio galenico sarà quindi quello di cercare piante con un sapore accettabile per una determinata indicazione o di mascherarlo del tutto.
93,2 %
senza allergeni*
*materie prime all'interno degli integratori alimentari
98.7%
non contengono glutine*
*materie prime all'interno degli integratori alimentari
98.5%
non contengono lattosio*
*materie prime all'interno degli integratori alimentari
85 %
Vegani*
*materie prime all'interno degli integratori alimentari